“La magia era avvenuta in quella pace, in quel silenzio, in quella penombra acquosa e ondeggiante: il suo bambino era venuto a parlarle. Non di parole vere e proprie si era trattato, ma di un vagito inarticolato, carezzevole, esalato da qualche parte in fondo alle casse di risonanza del corpo e della memoria”.
Il conto presentato dalle stagioni umane, dal tempo fisico e da quello interiore, è una delle storie – profondamente legate una all’altra – narrate da Enrico Bonadei in “Il tempo non esiste” (Giuliano Ladolfi Editore, 108 pagine). Qui ad esempio si parla della vecchiaia, di come l’anima possa tentare l’altrimenti 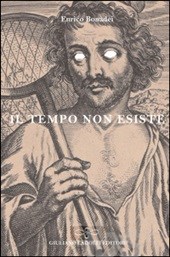 impossibile ricomposizione dell’unità e della felicità nonostante la solitudine, il corpo, la tentazione della resa. Ma è soprattutto la scrittura a rendere lieve il peso della storia, pur senza rimuovere la densità del dolore e della solitudine di una donna senza più affetti, senza una compagnia. Il destino di alcuni – anziani, malati, abbandonati – sembra quasi risarcito dalla inusuale capacità delle parole di penetrare e sprofondare dentro gli abissi di chi si prepara al suo ultimo viaggio. Ogni cosa attorno assume una carica simbolica e nello stesso tempo sembra entrare in comunione profonda con la protagonista. Il suo sguardo sul mondo diventa lentamente lieve addio e comprensione ultima del passaggio: dall’autobus guidato da un gentile e silenzioso autista, la donna può osservare un gattino spaventato con il quale ha tempo di “scambiarsi un’occhiata amichevole” e vedere la mano del conducente “mimare un cenno di rincrescimento e rassicurazione”. Raramente in questi anni la scrittura ha saputo ricreare un’atmosfera così commossa e nel contempo lieve, apparentemente noncurante, parlando anche e non solo di solitudine e morte.
impossibile ricomposizione dell’unità e della felicità nonostante la solitudine, il corpo, la tentazione della resa. Ma è soprattutto la scrittura a rendere lieve il peso della storia, pur senza rimuovere la densità del dolore e della solitudine di una donna senza più affetti, senza una compagnia. Il destino di alcuni – anziani, malati, abbandonati – sembra quasi risarcito dalla inusuale capacità delle parole di penetrare e sprofondare dentro gli abissi di chi si prepara al suo ultimo viaggio. Ogni cosa attorno assume una carica simbolica e nello stesso tempo sembra entrare in comunione profonda con la protagonista. Il suo sguardo sul mondo diventa lentamente lieve addio e comprensione ultima del passaggio: dall’autobus guidato da un gentile e silenzioso autista, la donna può osservare un gattino spaventato con il quale ha tempo di “scambiarsi un’occhiata amichevole” e vedere la mano del conducente “mimare un cenno di rincrescimento e rassicurazione”. Raramente in questi anni la scrittura ha saputo ricreare un’atmosfera così commossa e nel contempo lieve, apparentemente noncurante, parlando anche e non solo di solitudine e morte.
È la solitudine, però, uno dei punti di fusione di queste storie che non sono veri e propri racconti, ma diversi punti di vista attraverso i quali si intravede la medesima realtà. La realtà di una città d’Occidente che dovrebbe rappresentare il culmine di sorti magnifiche e progressive e che invece rivela l’altra faccia della storia, fatta di distanze, eccessive e non desiderate vicinanze, follia imputata all’altro che ci rivela improvvisamente la nostra, solitudine scambiata per malattia, paura che diviene violenza.
Niente da sperare, dunque? È la scrittura a rivelare la via d’uscita. Non perché presenti facili ricette, ma per la sua stessa natura, e d’altronde ormai sappiamo che lo scrivere non solo è una auto-terapia, ma può essere cura per l’altro. In essa si intravede chiaramente una pietas quasi religiosa per la sofferenza di chi è solo e perduto: sono parole, semplici parole, che talvolta da sole riescono a mostrare le cose da un’altra angolatura, fatta di silenziosa e misteriosa musica, sottile e gentile ironia.
Sembra non esserci niente di scontato nelle situazioni di “Il tempo non esiste”, dalla banale accettazione di un invito a stare assieme al desiderio di fondersi con il tutto (“fondermi in questo pulviscolo di oscurità, rilassarmi, sciogliermi, perdere forma e spandermi attorno come un liquido”). Ciò in cui riesce la scrittura è coniugare la ricerca del Portatore di Senso, come lo chiama Bonadei, con la leggerezza dell’esistenza, in un gioco di punti di vista dal quale sono assenti la retorica e il peso dell’io che molti autori si trascinano dietro.
È proprio dello scrittore di razza trasformare il peso in leggerezza, uscire da sé per fare posto alle cose, alle persone che, apparentemente per caso, appaiono nel proprio orizzonte visivo: “La vedo levare il naso per leggere il nome della via, consultare freneticamente una cartina. Come un piccolo animale sospettoso che fiuta l’aria, un piccolo animale in ritardo”.
È la scrittura stessa a possedere il dono della partecipazione, al di là dei suoi contenuti, come se da sola riuscisse segnare a dito le minime variazioni dell’esistenza, dall’incontro alla vecchiaia, e, infine, come la rassicurante mano dell’autista, accennare al mistero del Senso.
Marco Testi
